Ipersonnia: sonno onnipresente per una « iperpatologia »!
L’ipersonnia, o quando il sonno diventa stancante, che abusa del vostro tempo e della vostra salute. Questo motto avrebbe potuto essere estratto da una favola di La Fontaine, ma purtroppo è la cruda realtà a cui si va incontro quando l’ipersonnia fa capolino.
Patologia relativamente poco conosciuta nelle sue origini quando si presenta sotto forma di l’ipersonnia idiopatica, questa « super » o « iper » stanchezza cronica naviga nella vita delle persone che ne soffrono senza mai preoccuparsi della durata della sua crociera di sonno, né delle brevi soste della veglia. Origine incerta, anzi sconosciuta, conosciamo davvero le cause dell’ipersonnia?
Polimorfo, questo disturbo del sonno trova un porto d'attacco in diverse patologie e in numerose diagnosi. Ma allora, cosa si sa realmente sull'ipersonnia? Ecco alcuni elementi di risposta proposti dal Capitano Sonno, comandante della nave Hypersomnia!
L'ipersonnia, cos'è?
Secondo l'INSERM1 (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), l'ipersonnia si definisce come un disturbo neurologico caratterizzato da uno stato di affaticamento importante e da un bisogno eccessivo di sonno. Si manifesta anche con numerose sonnolenza diurna.
Si distinguono 2 tipi di ipersonnie :
- Ipersonnia primaria (o ipersonnia centrale): sono le più rare, e non si conoscono sempre le loro cause. Ne esistono 3 forme:
- ipersonnia idiopatica
- ipersonnia narcolettica
- ipersonnia ricorrente o sindrome di Kleine-Levin
- Ipersonnia secondaria: sono le più frequenti, spesso la conseguenza di un altro fenomeno (stanchezza, patologie, traumi, disturbi psicologici, assunzione di sostanze narcotiche…)
In generale, si considera che una persona sia ipersonniaca quando dorme più di 11 ore al giorno, il che costituisce una crociera del sonno piuttosto consistente!

L'ipersonnia in pochi numeri
L'ipersonnia è una malattia rara e, per questo motivo, è difficile da quantificare. Tuttavia, si stima la prevalenza dell'ipersonnia tra il 4 e il 6% della popolazione2 nella sua forma più frequente (ipersonnie secondarie, ad esempio l'ipersonnia psichiatrica).
Le ipersonnie primarie sono invece molto più rare, in particolare l'ipersonnia idiopatica. Quest'ultima colpirebbe da 1 a 5 persone su 10 000 (1-5/10 000)3 quando è accompagnata da un prolungamento della durata del sonno (fino a 10 ore), che è ad esempio 5 volte meno della prevalenza della narcolessia. Quando non è accompagnata da una durata del sonno prolungata, è ancora più rara, con una prevalenza che sarebbe dell'ordine di 1 su 100 0004.
L’ipersonnia idiopatica si manifesterebbe tra i 20 e i 30 anni, e colpirebbe uomini e donne. Tuttavia, ci sono pochissimi dati per quantificare ulteriormente l’ipersonnia.
Quali sono le cause dell’ipersonnia?
Le ipersonnie secondarie
Riguardano la maggior parte di noi e, contrariamente alle ipersonnie primarie, le cause delle ipersonnie secondarie sono identificabili. Possono colpire chiunque nel corso della vita, soprattutto quando derivano da una patologia o sono conseguenti a un disturbo del sonno. Ecco le principali ipersonnie secondarie :
- importante deficit di sonno, affaticamento fisico dovuto ad altri disturbi del sonno (narcolessia, apnea del sonno, sindrome delle gambe senza riposo)
- disturbi psichiatrici : depressione, distimia, bipolarismo…
- malattie neurologiche (neurodegenerazione, trauma)
- malattie infettive (virus Epstein-Barr, sindrome di Guillain-Barré)
- assunzione di sostanze : abuso di farmaci ipnotici o sedativi, interruzione improvvisa di stimolanti, solventi organici tossici…
- malattie endocrine o metaboliche : diabete, ipotiroidismo, insufficienza pancreatica o renale…
- cancro
Le ipersonnie primarie
Per questo tipo di ipersonnia, le cause non sono sufficientemente conosciute. Un’ipersonnia primaria non è la conseguenza di una malattia, di un disturbo psichiatrico o di un comportamento.
Tuttavia, si suppone che un cattivo funzionamento di alcuni sistemi di veglia possa essere la causa. Nel caso dell’ipersonnia idiopatica, sembrerebbe che il 20-30% dei casi segua a precedenti familiari5.
Si vede bene qui, le ipersonnie centrali (o primarie) rimangono ancora molto misteriose riguardo alle loro origini, forse ancora più di alcuni altri disturbi del sonno, conferendo così a questa crociera del sonno un carattere quasi soprannaturale! Ci sono infatti fenomeni che la scienza e la medicina non possono ancora spiegare bene.
I sintomi dell’ipersonnia
I sintomi dell’ipersonnia sono abbastanza caratteristici, anche se si riscontrano in altre patologie. Ecco i principali sintomi comuni ai diversi tipi di ipersonnie:
- stanchezza intensa, sensazione di esaurimento : voglia impellente di dormire, che può essere temporanea o costante a seconda del tipo di ipersonnia
- sonnolenza diurna eccessiva
- sonno lungo: prolungamento della durata del sonno
- difficoltà a svegliarsi: sindrome della « ubriachezza del sonno »
- ipovigilanza diurna
L’ipersonnia idiopatica presenta caratteristiche particolari:
- sonnolenza diurna eccessiva e costante
- sonno notturno normale o aumentato senza anomalie, ma non ristoratore
- risveglio molto difficile: inerzia e/o ubriachezza del sonno
- sonnellini lunghi e non riposanti
Nel caso di ipersonnia ricorrente/sindrome di Kleine-Levin, le caratteristiche sono le seguenti:
- episodi ricorrenti di più giorni
- disturbi cognitivo-comportamentali
- 15-20 ore di sonno al giorno, per diversi giorni, anche settimane
Per quanto riguarda la narcolessia, che è anch’essa considerata un’ipersonnia centrale, i sintomi di affaticamento e di prolungamento del tempo di sonno possono manifestarsi, ma è soprattutto caratterizzata dalla cataplessia (perdita del tono muscolare).
Come si può diagnosticare l’ipersonnia?
L’ipersonnia si diagnostica soprattutto grazie a un interrogatorio effettuato dal medico, oltre a un esame clinico e psicologico. Si pratica quindi una diagnosi di esclusione, cioè si cerca di eliminare le altre possibili cause di ipersonnolenza (stanchezza cronica, sovraccarico, sfasamento di fase, consumo di droghe ipnotiche o di farmaci sedativi, astinenza da droghe stimolanti…).
L’ipersonnia idiopatica è la più difficile da diagnosticare. A seguito di questo approfondito interrogatorio, dopo aver escluso le altre possibili cause di sonnolenza e la sindrome da stanchezza cronica, bisogna riconoscere e caratterizzare l’eccesso di sonno. Il medico può quindi indirizzare il paziente verso diversi esami:
- RM e/o TAC
- actimetria (dispositivo tipo braccialetto per misurare i ritmi di sonno e veglia)
- agenda del sonno (da compilare quotidianamente dal paziente)
- polisonnografia (analisi completa di una registrazione del sonno effettuata in laboratorio, grazie a elettrodi)
- test iterativi diurni di latenza dell'addormentamento
Per alcune ipersonnie secondarie, possono essere necessarie analisi complementari (imaging cerebrale, biologia) per caratterizzarle.
Oggigiorno, è abbastanza semplice « autodiagnosticarsi » per quanto riguarda la sonnolenza, effettuando un test online6 su siti o blog specializzati. Le risposte alle domande determinano facilmente problemi di sonnolenza diurna eccessiva grazie alla scala di Epworth. Non esitate a salire questa scala per saperne di più in caso di stanchezza o sonnolenza inappropriata!
A scopo informativo, Capitano Sonno, comandante della nave Ipersomnia, informa i più saggi tra noi (per non dire i più anziani!) che le eccessive sonnolenza diurna che iniziano a manifestarsi nelle persone anziane devono allertare queste ultime (o i loro familiari). Infatti, uno studio recente7 evidenzia che queste sonnolenza potrebbero essere precursori di malattie croniche, con « un rischio di diabete o ipertensione arteriosa moltiplicato per 2,3 » e « un rischio di cancro moltiplicato per 2 ». È quindi opportuno monitorare il sonno dei nostri gloriosi anziani (marinai)!
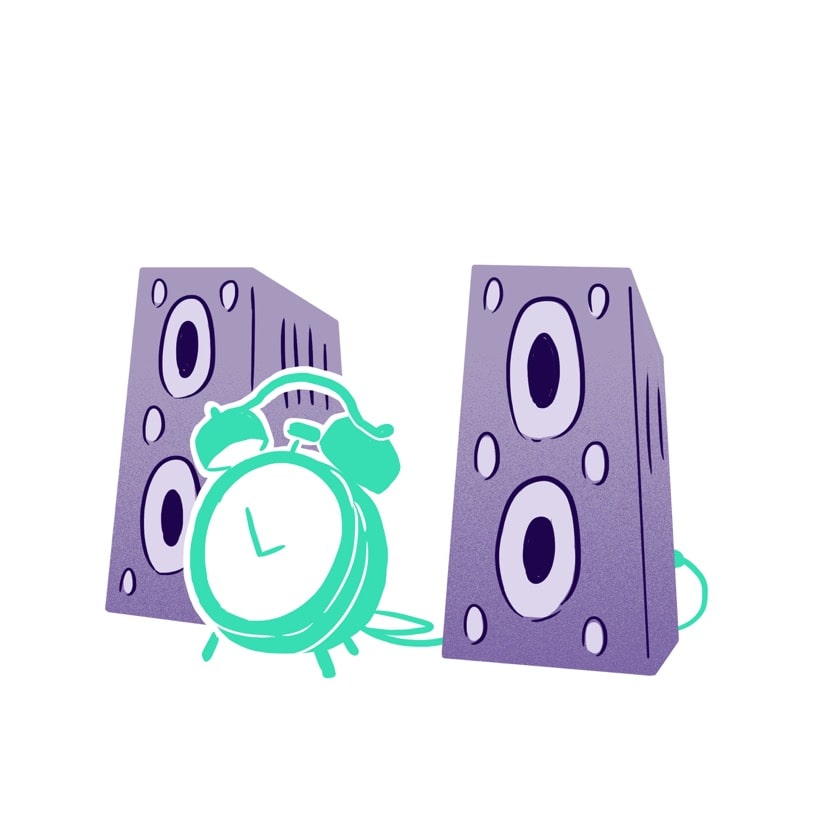
Quali trattamenti per l'ipersonnia?
Non si sa come curare l'ipersonnia, ci sono solo trattamenti sintomatici che permettono di ridurne gli effetti sui pazienti. La difficoltà a diagnosticare alcune ipersonnie centrali (ipersonnia idiopatica) e la gestione molto delicata dei farmaci associati fanno sì che il trattamento dell'ipersonnia, in quanto malattia rara, passi essenzialmente attraverso i «Centri di riferimento e competenza Narcolessia e Ipnosnie Rare ».
Il trattamento dei sintomi è essenzialmente farmacologico:
- per la sonnolenza diurna: assunzione di stimolanti della veglia (modafinil, metilfenidato, anfetamine)
- per la sindrome di Kleine-Levin: litio, valproato, corticosteroidi o trattamento per i disturbi del comportamento
- per l'ipersonnia narcolettica: ossibato di sodio, antidepressivi, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, pitolisant
Naturalmente, i trattamenti farmacologici comportano rischi di effetti collaterali. D'altra parte, quando il paziente soffre di ipersonnia psichiatrica, è estremamente difficile da trattare poiché alcuni antidepressivi causano essi stessi disturbi del sonno!
Inoltre, nel caso dell’ipersonnia idiopatica, gli stimolanti della veglia non hanno alcun effetto positivo sull’inerzia del risveglio (« ubriachezza del risveglio »).
In ogni caso, l’educazione terapeutica è indispensabile. Conoscere la propria malattia, rispettare un'igiene di vita adeguata (limitare il consumo di alcol, praticare attività fisica regolare…), mettere in atto « rituali del sonno » (orari fissi per i pisolini, il momento di andare a letto e di alzarsi) sono tanti riflessi quotidiani che possono alleviare i sintomi dell'ipersonnia.
Tuttavia, sono molto attesi progressi nell'identificazione delle cause di questa malattia e nei progressi terapeutici che ne deriverebbero per rendere l'esperienza della crociera del sonno un po' (o molto) meno gravosa! Quindi ricordatevi di compilare il libro « dort » prima di sbarcare!
Per illustrare l'argomento sull'ipersonnia, ecco un video del « Neuroscience Education Institute » che riassume le cause e le conseguenze di questo disturbo del sonno.
Fonti :
[1] et [4] Ipersonnie e narcolessia: quando dormire troppo è patologico, sito di « l’INSERM », settembre 2017 [2] Ipersonnia, Y. Dauvilliers, A. Buguet, « Dialogues in Clinical Neuroscience », dicembre 2005 [3] Ipersonnia idiopatica, sito « Orphanet », luglio 2020 [5] L’ipersonnia idiopatica, sito « Fondation Sommeil », 2020 [6] Soffrite di disturbi del sonno?, sito « Fondation Sommeil », 2020 [7] L’ipersonnolenza è un predittore significativo di nuove condizioni mediche tra gli anziani in uno studio longitudinale della popolazione generale, Maurice M. Ohayon, Shannon Sullivan et al, « Neurology », aprile 2020
